
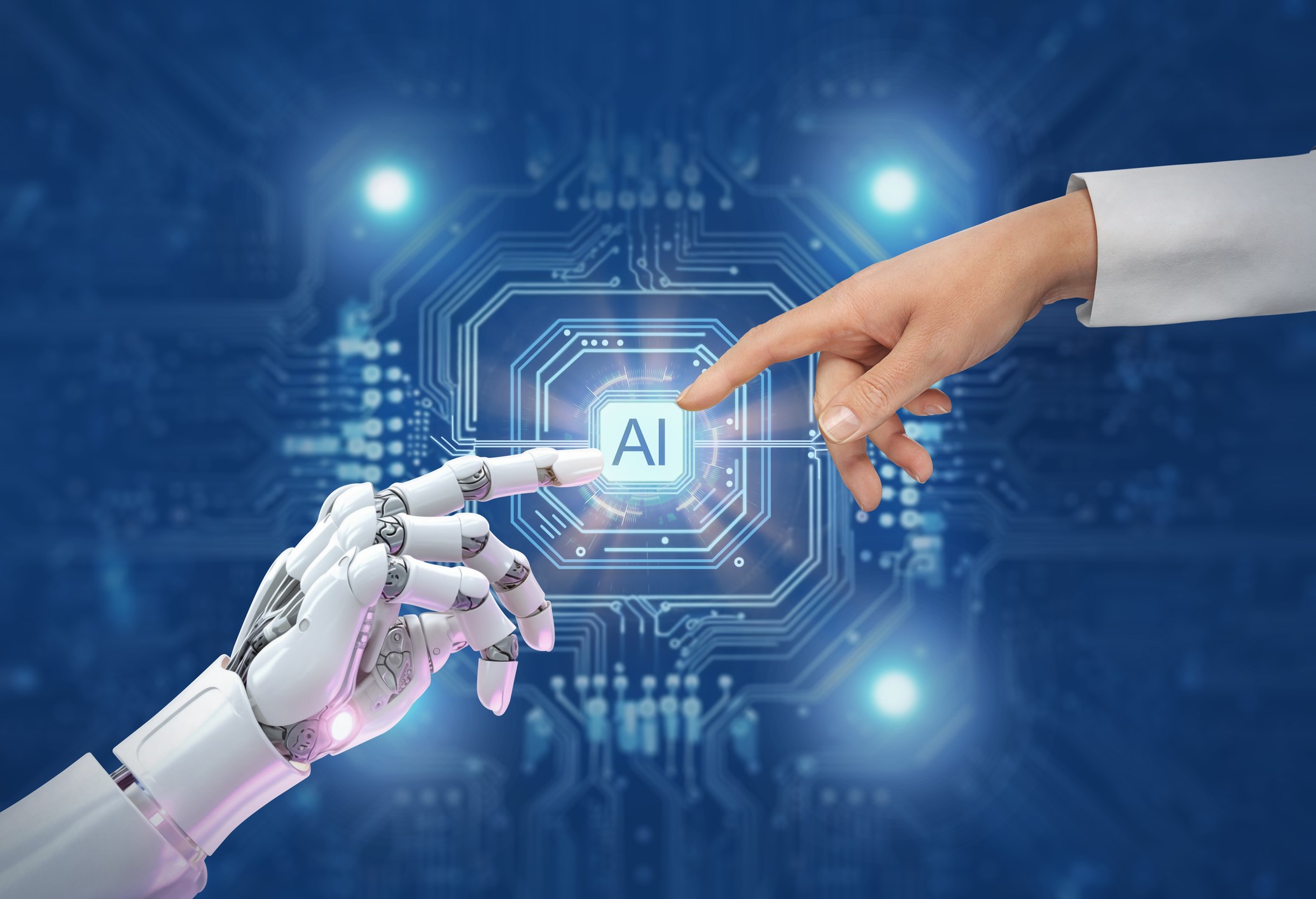
giovedì 18/07/2024 • 06:00
Intelligenza artificiale e Fisco: servono maggiori controlli
La relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato, pubblicata il 27 giugno 2024, consente di far riaffiorare la tematica riguardante il rapporto tra intelligenza artificiale e Fisco: bene le entrate tributarie, ma c'è bisogno di maggiori controlli sul campo.
di Marco Cramarossa - Dottore commercialista
di Maurizio Maraglino Misciagna - Dottore commercialista e revisore legale
- Tempo di lettura 1 min.
- Ascolta la news 5:03
- caricamento..
La relazione della Corte dei conti
Alcuni dati sono necessari per comprendere la sferzata dei magistrati contabili di fronte ai numeri e ai dati emergenti dalle entrate e dalle uscite relative al 2023. In generale, nel 2023 le entrate finali accertate (pari a 741,6 miliardi) sono cresciute del 4,2% rispetto al 2022. In aumento anche i versamenti totali, +3,3% (da 657,7 miliardi ai 679,2 miliardi del 2023), solo +1,8% quelli in conto competenza. Con particolare riferimento, per quanto qui di interesse, all'aggregato relativo alle entrate tributarie (imposte dirette e indirette), i dati evidenziano, rispetto all'esercizio precedente, un aumento, sia in termini di accertamenti (+6,9%) che di versamenti (+6,6%).
L'incidenza sul prodotto delle entrate accertate (618,5 miliardi) sale al 29,7% (dal 29,5% del 2022), mentre l'incidenza dei versamenti cresce solo di un decimo di punto al 28,1. Tra le indirette, che in termini di accertamenti (280,1 miliardi) segnano complessivamente un +5,1%, continua ad aumentare, pur se a ritmi meno sostenuti dello scorso anno, il gettito IVA grazie anche al profilo ancora in crescita dell'attività economica.
Tra le imposte dirette (338,2 miliardi, +8,4 gli accertamenti) l'IRPEF segna una variazione in aumento del 9,2%, cui si accompagna l'ulteriore incremento dell'IRES (+12,9%) dopo la forte crescita dell'esercizio precedente (+40%). In crescita del 12,9% le imposte sostitutive, le altre imposte dirette conoscono una flessione del 22% (riconducibile, soprattutto, al venir meno del prelievo straordinario a carico degli operatori del settore energia e gas).
La Corte osserva però che, nonostante i risultati positivi, è sempre consistente il numero dei contribuenti che non versano quote rilevanti delle imposte dovute e dichiarate: a fronte degli importi richiesti a seguito di comunicazioni di irregolarità, solo poco più del 20% viene corrisposto (la restante parte è iscritta a ruolo).
Elevata è anche l'incidenza dell'IVA, che costituisce circa il 60% del non versato. Lo stesso accade per i controlli documentali: delle somme dovute sono versate in media meno del 30 per cento. Un fenomeno che risulta ancora più grave quando accompagna misure come le rottamazioni delle cartelle esattoriali con consistenti vantaggi per i singoli contribuenti: è il caso della rottamazione quater che, pur presentando un risultato superiore alle attese, a fronte di 6,8 miliardi riscossi, registra omessi versamenti di rate per 5,4 miliardi. Circostanza, quest'ultima, sia consentito dirlo, che dovrebbe far riflettere molto sulle premialità concesse con le misure condonistiche che sistematicamente vengono riproposte nel nostro Paese.
Per un altro verso, guardando all'azione dell'amministrazione tributaria per il recupero del gettito, se crescente rilievo assume l'invio delle c.d. lettere di compliance, continuano invece a essere inferiori ai risultati pre-pandemia (e a ridursi ancora nel 2023) gli accertamenti dell'Agenzia delle entrate: oltre 175 mila contro i circa 190 mila del 2022 e i 267 mila del 2019 (quelli ordinari). Un calo che è strettamente correlabile, da un lato, alla riduzione di personale verificatasi nel tempo, a cui nel 2023 si è cominciato a far fronte, e, dall'altro, al permanere della difficoltà a un pieno e completo utilizzo delle banche dati tributarie e, in particolare, di quelle relative alle fatture elettroniche e ai rapporti finanziari. Strumento centrale di una moderna strategia di contenimento dell'evasione, che dovrebbe comunque essere affiancato da una maggiore frequenza dei controlli, non limitati alle posizioni rilevanti, ma caratterizzati da un'azione più estesa, necessaria per contrastare l'evasione diffusa che tuttora caratterizza la situazione italiana, soprattutto attraverso l'utilizzazione in chiave (prima di tutto) preventiva della ingente mole di dati a disposizione del sistema informativo, insieme a tutte le altre informazioni di cui dispone l'Agenzia delle entrate (dati contabili, dati strutturali, consumi, ecc.), in conformità alla volontà espressa dal Legislatore sin dal dicembre del 2019.
La relazione della Corte ricorda che, in ordine alla effettiva utilizzazione dei dati finanziari per l'analisi di rischio, l'Agenzia ha fatto sapere di aver realizzato una procedura per individuare elenchi di contribuenti che presentano elementi di forte incoerenza tra redditi/ricavi dichiarati e movimentazioni finanziarie, elaborati a livello centrale mediante specifici criteri basati sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri dati presenti in Anagrafe tributaria e rese disponibili agli Uffici mediante un apposito applicativo a base algoritmica (denominato “Ve.R.A. – Verifica Risparmio accumulato”). Andranno, comunque, attentamente monitorati gli effettivi risultati conseguiti, soprattutto in termini di concreta proficuità dell'attività.
Anche in ambito catastale, evidenzia la relazione dei giudici contabili, per agevolare le attività di indagine territoriale, nel 2023 è stata sviluppata una piattaforma vettoriale sul SIT, nella quale una prima fotointerpretazione di incoerenze catastali, desunte dal confronto della cartografia vettoriale con le ortofoto (al momento per individuare fabbricati e piscine non rappresentate nella cartografia catastale), è effettuata da un sistema di machine learning, opportunamente addestrato su specifici data set, che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale. Gli esiti di questa fotointerpretazione automatica possono essere poi controllati, validati e integrati dagli operatori.
Osservazioni
Nel corso del 2024 sarà effettuata una sperimentazione di indagine territoriale su un comune per valutare il passaggio a questa nuova piattaforma che consentirà la velocizzazione delle attività in argomento, anche grazie allo sviluppo di nuove funzionalità di disegno realizzate direttamente sul SIT vettoriale.
Sempre in tema di intelligenza artificiale, grandi aspettative sono riposte nell'Unità per l'Analisi del Rischio (UPAR), ovvero un organismo specializzato con cui, in sintonia con la delega fiscale, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza (con il supporto di Sogei), ciascuna per il contributo di propria competenza, attraverso l'uso di algoritmi, intendono valutare e gestire in via preventiva i rischi legati a diversi settori, tra cui quello economico-finanziario, sanitario e ambientale, con l'obiettivo di garantire maggiore stabilità e sicurezza.
Il primo compito dell'UPAR è la raccolta e l'analisi di dati provenienti da una vasta gamma di fonti, come database interni, enti governativi, istituzioni internazionali e organizzazioni private. Utilizzando strumenti avanzati di analisi, tra cui tecniche di intelligenza artificiale, data mining e machine learning, con addestramento mirato a riconoscere aree di rischio non conosciute e conoscibili, l'UPAR dovrebbe riuscire a identificare pattern e tendenze che potrebbero indicare potenziali rischi. Una volta raccolti i dati, l'Unità procede con la valutazione dei rischi, analizzandoli in termini di probabilità e impatto e classificandoli in base alla loro gravità. Questo processo include anche la realizzazione di simulazioni e scenari per comprendere meglio le possibili conseguenze dei rischi e preparare strategie di mitigazione adeguate.
L'UPAR nell'ambito fiscale mira a individuare in tempo reale i presupposti fenomenici legati all'evasione e alle frodi fiscali, come la creazione di partite IVA false, mirati alla costruzione e all'utilizzo di cartiere o delle cosiddette “bare fiscali”.
Sullo sfondo, al netto del tempo necessario per perfezionare e collaudare lo strumento, c'è sempre la necessità di interagire, da un lato, con le prescrizioni in materia di privacy e, dall'altro, con i sacrosanti principi stabiliti dal Consiglio di Stato, con le sentenze del 2019 (nn. 2270 e 8472), che riconoscono la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato (i.e. codice algoritmico) e dei criteri applicati, nonché la precisa imputabilità della decisione all'organo titolare del potere. Temi, peraltro, che il legislatore italiano sembra voler valorizzare con il DDL in tema di “Norme di principio in materia di intelligenza artificiale”, posto che si precisa che i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità e della spiegabilità.
|
Intelligenza artificiale, imprese e professioni: come l'AI e gli algoritmi stanno rivoluzionando il mondo imprenditoriale e professionale. |
 Quotidianopiù è anche su
WhatsApp! Clicca qui per
iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
Quotidianopiù è anche su
WhatsApp! Clicca qui per
iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Iscriviti alla Newsletter
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Trovi interessante questo video?
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.